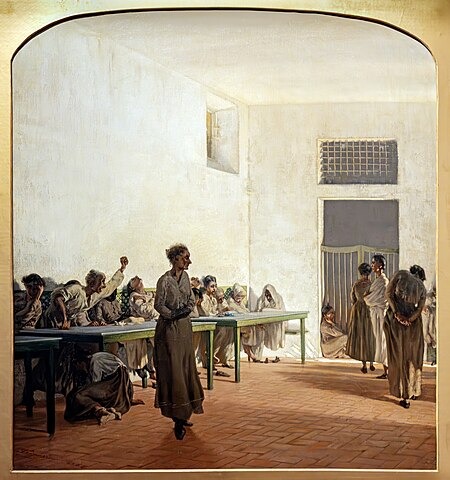Il New York Times Magazine ha di recente pubblicato un articolo, firmato da Matthew Shaer, incentrato sulla solitudine come vera e propria crisi, incrementata dalla pandemia dovuta al Covid ma in realtà abitante le pieghe del tessuto sociale già da prima. La solitudine si presenta come una sensazione composita o multidimensionale, avente elementi di tristezza ma anche di ansia, paura e angoscia. Si
tratta, dunque, di un’esperienza intrinsecamente soggettiva e che pertanto non è facilmente comprensibile da chi non ne è affetto o crede di non esserlo. Ciò che l’articolo pone in evidenza è
anzitutto la relazione tra la sensazione di solitudine e il venir meno di spazi condivisi. Laddove, comunque, vi sia disponibilità di una vicinanza fisica con diversi soggetti, può darsi che manchi la vicinanza emotiva e con essa la prospettiva della creazione di un rapporto che possa definirsi significativo. Con la pandemia ha prevalso lo smartworking e questa sorta di pendolarismo virtuale si è rivelato, sì, efficace nell’abbattimento dei costi e nell’aumento della produttività, ma ha danneggiato tutti i progressi – in atto o in potenza – aventi a che fare con la costruzione di una comunità, e con quello che è il senso di comunità. Avere un luogo di lavoro diverso dalle stanze di casa permette di stabilire connessioni con persone esterne al nucleo familiare, con le quali si possono scoprire affinità o interessi, e dalle quali possono anche scaturire stimolanti occasioni di confronto e dibattito.
L’articolo termina con l’analisi dello spazio digitale, e con la visione della crisi di solitudine come periodo di acclimatamento di massa e passaggio evolutivo, durante il quale scendiamo a compromessi e ci apriamo ad altre maniere di fare comunità. Ciò che mi domando ora è: quanto noi – esseri umani viventi diversi luoghi nel corso di una medesima giornata – siamo consapevoli del modo in cui abitiamo i luoghi. Che cosa significa abitare? Che cosa è lo spazio o il luogo? I modi dell’abitare possono essere i più disparati, credo, e penso che vadano dall’insinuarsi silenziosamente in un contesto al prendere coscienza del fatto che, una volta entrati a far parte di un determinato ambiente, si abbia voce in capitolo rispetto ad eventuali cambiamenti dello spazio medesimo. È un nostro diritto abitare uno spazio e farlo nostro poco a poco, non solo acclimatandocisi, ma anche per esempio avanzando proposte di modifica di alcuni aspetti o rendendolo più colorato nel senso di cromaticamente affine al nostro umore e al nostro essere. Quante e quanti di noi sentono la necessità di rendere propria la stanza affittata da fuorisede? Nel momento in cui si mette mano alla stanza – attaccando poster, accendendo candele o, ancora, mettendo in bella vista foto e ricordi – si sta modificando un contesto. Perché certo che quella stanza appartiene a chi la affitta per il tempo in cui l’affitta, ma essa è già inserita in una normalità che non ci appartiene totalmente, e su cui può risultare dapprima complicato affacciarsi, soprattutto se non ci si è domandati che significato abbia abitare lo spazio per sé. Qual è la relazione tra solitudine e abitazione degli spazi? Perché sì, penso che una relazione ci sia e che la solitudine non sia solo conseguenza della mancata comunanza di luoghi, ma anche del volontario o inconscio allontanamento da un luogo in seguito ad un’autocritica più o meno schietta del modo in cui abitiamo gli spazi. Mi spiego meglio: definisco spazio tutto ciò che ha a che fare con la costruzione di collegamenti emotivi con persone e oggetti. Non parlo perciò solo di spazi fisici, come una camera o il parco pubblico, ma anche di spazi interiori, come quelli che vediamo nelle nostre fantasie e nei nostri sogni, e di spazi drammatici, quali possono essere quelli in cui ci immergiamo leggendo un libro o assistendo ad uno spettacolo teatrale. Può darsi che, talvolta addirittura sorvolando sulla domanda circa il modo in cui abitiamo qualsivoglia luogo, arriviamo alla conclusione impietosa che non siamo in grado di abitarlo come le persone giudicano dovremmo fare o come il nostro lato più critico vorrebbe facessimo. Ciò potrebbe portare a ricercare l’isolamento fisico come fosse l’unico rifugio sicuro disponibile, non tenendo però nella giusta considerazione la riflessione attorno alla maniera di declinare il proprio essere nei luoghi dell’agire. Potrebbe poi portare anche a sentirsi soli nel senso di sentire di non essere capiti, di essere continuamente fraintesi, di essere travisati senza che ci sia, da parte degli altri, sforzo alcuno per stabilire un contatto emotivo che vada al di là della semplice apparenza o del giudizio superficiale rispetto alla goffaggine o insicurezza con la quale ci si approccia ad un luogo. Oltre, quindi, alle osservazioni sociali presentate nell’articolo – che è disponibile sul sito di Internazionale nel numero 1581 – ritengo che sia fondamentale dare il giusto rilievo al porsi di questioni essenziali e al contenuto delle nostre risposte. Chi siamo quando abitiamo gli spazi? Cosa cambia, nel nostro modo di agire, quando passiamo da uno spazio individuale ad uno spazio collettivo? Cosa ci soddisfa della nostra declinazione dell’abitare e cosa meno? Se ci troviamo davvero in un periodo di acclimatamento di massa, è il momento giusto per prenderci il tempo di sottoporci a queste domande, e provare a darvi delle risposte.