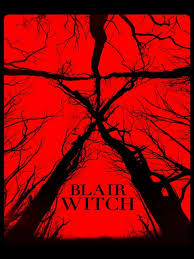Tra tutti i generi cinematografici, l’horror è forse uno dei più difficili da sfruttare in maniera originale e intelligente. Probabilmente perché così collegato a sentimenti atavici e profondamente “di pancia”, realizzare un film spaventoso può per certi versi essere molto semplice, ma girarne uno che faccia scuola e che resti impresso nell’immaginario collettivo di intere generazioni è tutta un’altra storia. La paura è, di per sé, un qualcosa di molto facile; produrla con mezzi e temi inediti no.
The Blair Witch Project è un esempio di film horror che ha segnato una pietra miliare del genere e lo ha fatto a bassissimo budget, con un cast ridotto all’osso, ma facendo leva su ciò che agli immaginari orrorifici spesso manca: la creatività. Anche se si tratta di un’originalità alquanto macabra.
Il film uscì nelle sale nel 1999, dopo appena due anni di lavoro da parte dei co-registi Daniel Myrick e Eduardo Sanchez e solo 8 giorni di riprese. Il budget stanziato per il progetto era di soli 35000 dollari, una cifra irrisoria se si conta che il film ha avuto un successo tale da incassare 250 milioni. Una simile esplosione mediatica si deve probabilmente alle scelte registiche usate nella narrazione, che fanno uso magistrale della tecnica found footage. La tecnica consiste nel montare il film per dare l’impressione che le immagini mostrate al pubblico siano state “ritrovate” (magari all’interno di file dimenticati o dentro vecchie videocamere) e semplicemente riassemblate dai registi che, appunto, “ritrovano” il girato. L’idea è di dare più realismo possibile alla storia, come se essa non fosse un’opera di finzione, bensì un qualcosa di veramente accaduto, filmato e solo successivamente portato alla ribalta. Se si pensa poi che la storia in questione è profondamente disturbante, l’ipotesi che essa potesse essere avvenuta davvero riuscì a fare ancora più presa sul grande pubblico.
La trama racconta di tre giovani studenti, Heather, Mike e Joshua (i veri nomi degli attori che li interpretavano, una scelta voluta per conferire ancora più realismo ai dialoghi basati sulla totale improvvisazione), che si avventurano nei boschi che circondano la piccola cittadina di Burkittsville, nello stato del Maryland. Il loro intento è quello di girare un documentario sul folklore locale, che da generazioni tramanda la leggenda della cosiddetta “Strega di Blair” (antico nome del villaggio), che si dice abiti proprio quei boschi. I tre giovani si dirigono dunque tra gli alberi con l’intento di campeggiarci per qualche giorno alla ricerca di prove sull’esistenza della strega, non prima di aver anche intervistato alcuni degli abitanti di Burkittsville sulla sua storia.
E’ proprio qui che a cadere nel tranello del found footage non fu solo il pubblico in sala, ma anche il cast stesso del film. I registi, infatti, nel corso delle riprese convinsero gli attori che la leggenda fosse vera, o che comunque appartenesse davvero al folklore del luogo. Il cast era dunque convinto di star girando un film su una storia potenzialmente realistica, impressione rafforzata dalle loro interazioni con gli abitanti di Burkittsville. Questi ultimi, però, erano anch’essi attori, il cui ruolo principale era proprio quello di generare ancora più ansia ai protagonisti, all’oscuro del fatto che l’ambientazione fosse di completa finzione.
La recitazione fu un altro degli strumenti usati in maniera più originale per creare un senso di terrore costante non solo nel pubblico, ma anche nel cast. Il copione era di appena una trentina di pagine e senza alcuna linea di dialogo; l’obiettivo era che l’intera pellicola fosse girata basandosi sulla mera improvvisazione, con gli attori che ricevevano dalla troupe prompt personalizzati su base quotidiana da seguire come canovacci. Di conseguenza, ogni singolo dialogo del film è frutto dell’immedesimazione totale degli attori con i propri personaggi, un confine che i registi avevano intenzione di assottigliare il più possibile.
Nessuno dei giovani attori era a conoscenza dell’effettiva trama del film, ma solo di ciò che di giorno in giorno avrebbero dovuto fare. I prompt che ricevevano erano studiati apposta per creare conflitti tra di loro, ad esempio chiedendo a uno di loro di distruggere l’unica mappa a disposizione, così come il cibo che gli veniva fornito dalla troupe si faceva di giorno in giorno più scarso, con la precisa intenzione di rendere il cast più vulnerabile e teso. La troupe portò questa forma di regia sperimentale ancora più in là: la tenda dove i protagonisti dormivano venne scossa in piena notte, spingendo gli attori a precipitarsi all’esterno gridando di terrore e dando origine a una scena autentica e cruda; casse che riproducevano inquietanti risate infantili vennero posizionate intorno all’accampamento e accese dopo il tramonto; il bosco fu riempito di inquietanti sculture e tumuli di pietre. Si trattò si scelte scenografiche di cui il cast fu volutamente lasciato all’oscuro e che avevano il chiaro scopo di generare un clima di angoscia e terrore crescente e autentici negli attori, sempre meno bisognosi di ricorrere alla recitazione per dar vita ai loro “personaggi”.
La stessa strega, a schermo non appare mai, perché nell’unica scena in cui sarebbe dovuta comparire (proprio quella della tenda scossa) il cast era talmente preso dalla paura da dimenticarsi di accendere le proprie videocamere, come gli era richiesto da contratto.
The Blair Witch Project è, dunque, un film che ha fatto storia e scuola, ma lo ha fatto spingendosi ai limiti della legalità e sconfinando senza troppi problemi in veri e propri abusi psicologici. Heather Donahue, una dei protagonisti, ha dichiarato che a riprese iniziate era convinta che sarebbe morta e che il film in cui stava “recitando” fosse uno snuff movie.
Quando guardiamo questo film non assistiamo a un semplice spettacolo, ma ci interfacciamo con una paura cruda e reale, creata in un laboratorio cinematografico alle spese di tre giovani ignari di tutto e che nel corso della storia si trasformano nei loro personaggi in maniera totale e paurosa. E’ un capolavoro, su questo non c’è dubbio; ma lo è perché è riuscito a dimostrare che gli incubi possono trasformarsi in realtà e che l’horror, in ogni sua dimensione, non ha bisogno di mostri per realizzarsi. A volte bastano due registi, una videocamera e un’etica molto blanda.
BIBLIOGRAFIA:
Phil Hoad, How we made The Blair Witch Project, “The Guardian”, 21 maggio 2018