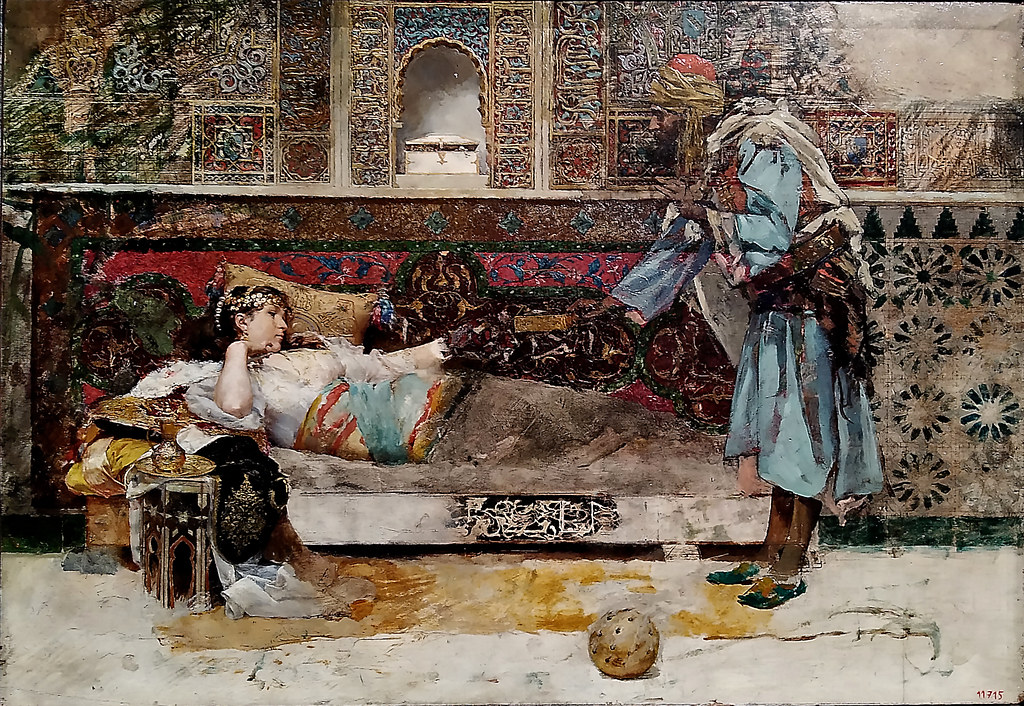C’è stato un tempo in cui l’intelligenza era solo un requisito da CV. Ora è un accessorio da outfit. “Thinking is becoming a luxury good”, come scriveva Mary Harrington, firma del New York Times, espressione che marca nuove nuances di disuguaglianza. Nel feed di Instagram, tra una colazione proteica e un tramonto filtrato Mykonos, spunta sempre lei: la persona che legge. Libro in mano (preferibilmente Einaudi bianco o Adelphi dai toni sgargianti), caption postmoderna e via di fama da intellettualoide.
Al pari del capitale economico, anche quello culturale va esibito, sfoggiato. La conoscenza è, però, un bene astratto e bisogna dunque concretizzarla: con outfit specifici, condivisione di contenuti e citazioni ben calibrate. Potremmo definire la letteratura un accessorio semantico: “ah sì, come diceva Barthes”.
Non importa se non hai letto Barthes, importa come lo pronunci.
Il libro, oggetto quasi sacro, torna così a essere simbolo di distinzione: costa poco, dura tanto e, Marx perdonami, genera plusvalore culturale.
Leggere diventa un investimento a rendimento estetico: compri un libro per comprare anche una nuova versione di te stessa, più raffinata e più esclusiva.
La cultura, dunque, non è più solo consumo, è posizionamento. Leggere Bolaño, citare Žižek con ironia sono tutti gesti performativi, segni di distinzione.
E come ogni forma di distinzione, anche i segni hanno bisogno di essere visti.
Ed eccolo, il protagonista.
Il performative male, una discussione che non accenna a terminare.
Lui si presenta così: look minimale, barba curata, foto in bianco e nero con un libro di David Foster Wallace (possibilmente Infinite Jest, anche se non l’ha finito) e sorseggia un bicchiere di matcha, “perché ama la cultura giapponese”.
Il nucleo della problematica non risiede negli atteggiamenti che l’uomo performativo emula, ma nella motivazione sottostante: l’adozione deliberata di tale modello avviene per la pura e semplice intenzione di attrarre o compiacere il sesso opposto, trasformando l’espressione di sé in un atto strategico di compiacenza relazionale.
È il maschio postmoderno autodidatta di un teorema: la cultura per essere desiderabile, deve sembrare autocritica. Per quanto non voglia essere fatalista, il performative male è, in effetti, il sintomo perfetto del nostro tempo. È la rappresentazione di un desiderio collettivo: voler essere percepiti come profondi in un mondo che ci rende superficiali.
E mentre il pensiero diventa un accessorio, l’editoria, quella signora elegante che tutti davano per morta, può finalmente tornare sulla scena. Non più come industria della carta, ma come ecosistema di esperienze cognitive. Non limitandosi a vendere libri, bensì spazi mentali, identità narrative, luoghi dove riconoscersi e un po’ perdersi.
Il libro non è solo prodotto, ma posizionamento mentale: un oggetto che comunica chi siamo, ma che, miracolosamente, invita anche a metterlo in discussione.
Le case editrici possono parlare a questo nuovo pubblico di performative thinkers non con paternalismo, ma con ironia e complicità. Riconoscendo che leggere, oggi, è un gesto insieme estetico e politico. Chi legge si sottrae, anche solo per un momento, alla bulimia del caos.
Forse i libri non cambieranno il mondo, ma possono cambiare il modo in cui lo si abita.
E per far contenti i miei amici performativi, lo cito anche io: David Foster Wallace lo aveva previsto (forse tra una nota a piè di pagina e una crisi esistenziale). I libri non parlano più alla maggioranza. Il pensiero è l’ultima forma di lusso accessibile: ma solo a chi sa come indossarlo.