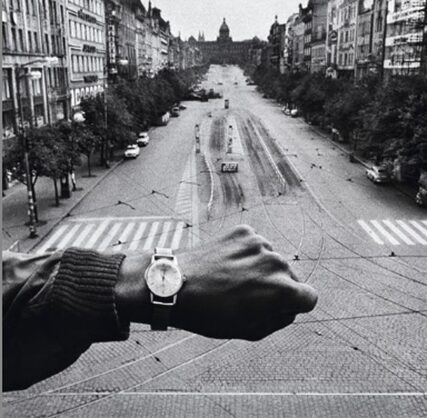“Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato” (da 1984, di George Orwell)
“Papà, allora spiegami a cosa serve la Storia.” Così Marc Bloch comincia quella che è la sua opera più famosa, Apologia della storia, riportando la domanda, tanto innocente quanto ardua, posta da un figlio a un collega storico. L’intera opera sarà poi incentrata sul tentativo di rispondere a questo quesito.
Ora, personalmente, io Apologia della storia l’ho appena iniziata a leggere: non conosco ancora, se non in linea generale, il pensiero di quello che è considerato il più grande storico del ’900. Tuttavia, posso affermare con certezza che, se alla domanda sull’utilità della storia Bloch ha risposto con un tomo che supera le quattrocento pagine, l’attuale ministro dell’Istruzione (e del Merito), Valditara, ha aperto i documenti sulle nuove linee guida per l’insegnamento della storia con una frase a dir poco terrificante: “Solo l’Occidente conosce la storia.” Una frase che, oltre a far accapponare la pelle a me personalmente, credo lo farebbe anche a tutti gli storici contemporanei — e a Bloch stesso.
D’altra parte, lo stesso storico francese, pur scrivendo in anni in cui ancora non si parlava chiaramente di “eurocentrismo”, sosteneva comunque la necessità di una storia comparativa, nella quale si ricercassero analogie e differenze nel percorso di tutte le società. Soprattutto, non parla mai di una storia europea come “superiore” alle altre.
Bloch fu anche lo storico che, insieme al collega e amico Lucien Febvre, fondò una pietra miliare nella ricerca storica: Les Annales d’Histoire Économique et Sociale, rivista che raccoglieva attorno a sé un gruppo di studiosi intenzionati ad affermare una nuova idea di storia — una storia “dal basso”, concentrata su prospettive economiche, sociali e antropologiche, piuttosto che sulle azioni della grande politica e dei grandi personaggi europei. Una storia che, dunque, rappresentava un implicito atto di messa in discussione della storiografia elitaria ottocentesca.
Ora, se a queste conclusioni era già arrivato Bloch e la storiografia dei primi decenni del ’900, che cosa spinge, nel 2025, il Ministero dell’Istruzione (e del Merito) a giungere a conclusioni tanto diverse?
La risposta, credo, sia essenzialmente una sola: la volontà di usare la Storia come strumento per il rafforzamento dell’identità nazionale, in linea con la politica generale del governo. Una volontà che è dettata, però, da un’estrema ignoranza, e che porta ad affermazioni false come quella secondo cui sarebbe solo l’Occidente a “conoscere la storia”. Si finisce così per promuovere una prospettiva eurocentrica ancora più radicale — come se non fosse da anni ormai che si ripete che, nell’insegnamento della storia, questa visione dovrebbe essere abbandonata, anche solo per smettere di raccontare gli altri continenti come semplici scenari di conquiste, spedizioni e scontri tra potenze europee.
Forse sarebbe anche ora di aumentare le ore scolastiche a disposizione degli insegnanti di Storia. E invece no: si punta su questo, sul latino e sulla Bibbia. D’altra parte, bisogna pur formare “gli italiani di domani”. E cosa c’è di meglio, quindi, che adottare un’ottica nazionalista (seppur allargata all’Occidente) e valorizzare le comuni radici linguistiche e religiose?
Da qui scaturisce anche una riflessione ancora più preoccupante, che nasce da precedenti dichiarazioni dello stesso Valditara, il quale annunciava, per le nuove linee guida, una “Storia senza ideologie”. In questo caso, il pensiero corre a un periodo storico in particolare: il fascismo. È un pensiero che nasce direttamente dalla storia politica dell’attuale maggioranza di governo, che ha sempre teso a una rilettura del Ventennio più “morbida”, e talvolta persino positiva, contrapposta a quella storiografia “di sinistra” che ha costruito l’attuale narrazione degli eventi legati al fascismo, alla guerra e alla Resistenza.
Dimenticano però una cosa fondamentale: lo storico può anche avere una sua personale visione del mondo ed esprimere determinate idee politiche, ma quando parla o scrive da storico, lo fa supportato da fonti che attestano fatti realmente accaduti. Si può discutere sulle interpretazioni di un determinato avvenimento, ma non su ciò che si sa essere accaduto con certezza.
Fare il contrario significa manipolare la storia e nascondere gli avvenimenti per paura di affrontarli — per codardia o per tornaconto politico.
D’altra parte, non si capisce in nessun’altra maniera la necessità di scrivere nuove linee guida per l’insegnamento della disciplina storica, se non con l’intento di proporre una narrazione più allineata a determinate idee politiche della maggioranza, fornendo così anche basi ideologiche apparentemente più solide.
Certo, la prima vittima è poi la Storia stessa.