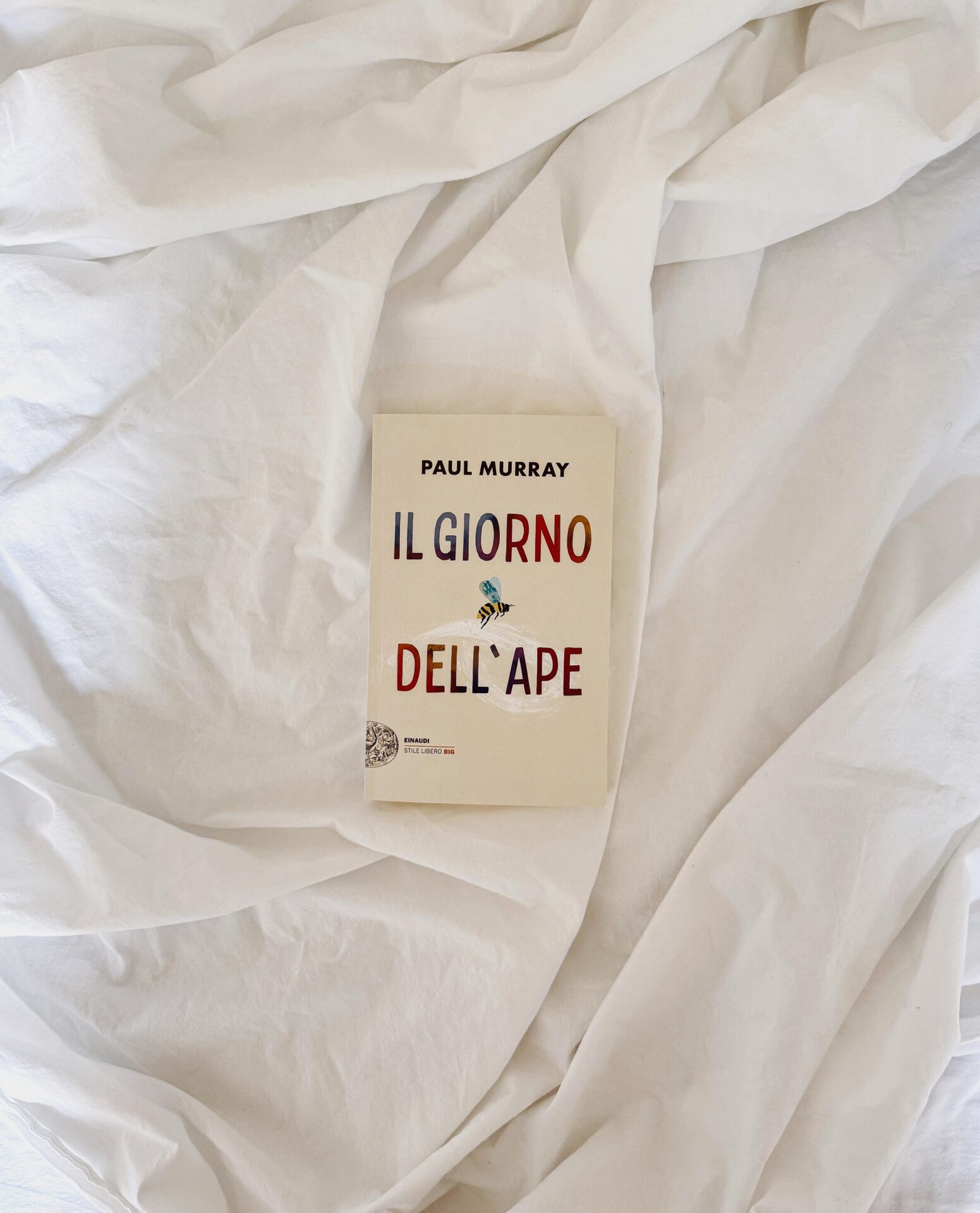Se pensate che la storia della lingua italiana sia un pacifico susseguirsi di accademie e grammatiche, non avete mai messo alluce a teatro. Tra il XVI e il XVII secolo, il palcoscenico non è stato un salotto, ma laboratorio privilegiato della dialettica lingua/dialetto; spazio dove il binomio vernacolo-commedia fungeva da specchio delle trasformazioni sociolinguistiche del Paese. E se nel Cinquecento il dialetto debuttava per legittimare una cultura popolare frammentata, nel Novecento lo ritroviamo come reperto antropologico di un’identità ormai defunta.
Nel primo caso, la commedia compie il suo parricidio: abbandona il latino delle rappresentazioni plautine per abbracciare il volgare. Il Prologo della Calandra di Bibbiena è il manifesto di questa modernità: «vulgare, non latina». Eppure, questo volgare non ha nulla da spartire col monolite toscano teorizzato da Pietro Bembo. Mentre gli intellettuali d’élite si perdevano in speculazioni, il teatro doveva fare i conti con la “funzione d’impatto”.
È Ruzante, nel Prologo della Vaccaria, a smascherare l’ipocrisia dei letterati con sentenza definitiva, passata in giudicato: «molte cose stanno ben nella penna, che nella scena starebben male». La realtà linguistica quotidiana, radicata nel mondo contadino, non si lasciava certo addomesticare dalla pagina scritta.
La commedia si è sempre distinta per la capacità di esprimere una protesta che è linguistica e, per estensione, sociale. La complessa fenomenologia del plurilinguismo mette a nudo le strutture di potere: il linguaggio delle classi egemoni è modello di autorevolezza, mentre il dialetto è marchiato come segno di subattività e rusticità.
Tuttavia, con Beolco, il contadino irrompe sulla scena con l’impeto della snaturalité. Il dialetto pavano non è mero esercizio di realismo in linea con la mimesis aristotelica, ma autentico armamento critico. Nel dialogo della Pastoral, il contrasto tra i registri è brutale: alla supplica elevata e quasi liturgica di Arpino («O sacro Pan, pieta d’i servi toi!»), Ruzante risponde con la concretezza del basso corporeo: «Tu me vuo dar del pan?». Non è una battuta, è una denuncia: la fame del contadino ridimensiona la retorica solenne della cultura dominante, rivelandone l’essenza ipocrita.
Anche nella Mandragola, il plurilinguismo serve a tracciare i confini della sopraffazione. Il giovane Callimaco, forte della sua aderenza al fiorentino “argenteo”, raggira Messer Nicia con una facilità disarmante. Nicia, prigioniero di un parlato fatto di espressioni popolari e allusioni oscene, è la vittima perfetta: la sua lingua lo condanna alla subalternità, rendendolo incapace di decodificare l’inganno del potere.
Se nel Cinquecento la tensione tra lingua e dialetto era all’alba, oggi siamo alla celebrazione delle esequie. Il Novecento osserva la progressiva scomparsa del dialetto, la morte di un patrimonio fondato su concretezza e rapporto diretto con la natura.
In questo contesto, la ricerca linguistica di Dario Fo non è fine a sé stessa, ma risponde alla necessità di riafferrare valori estinti. Mentre Ruzante operava la mimesi di una realtà rurale ancora pulsante (seppur sofferente), Fo opera la mimesi della memoria. Gianfranco Folena definisce il “magma pluridialettale” di Fo come un “certificato di morte” del dialetto, un’eco di un popolo della campagna ormai scomparso. Nel suo Mistero Buffo, Fo utilizza il grammelot, una lingua giullaresca che mescola il lombardo occidentale a suoni padani, per dar voce a un Medioevo immaginario, popolato di oppressi. È l’espressione dialettale di un mondo che non esiste più, un atto di resistenza contro le ingiustizie dei secoli passati.
La tensione tra tradizione e innovazione rivela oggi un panorama desolante. Se un tempo il dialetto era una forma di resistenza eversiva, nella “società liquida” contemporanea le tensioni sembrano essersi allentate. I ceti egemoni e quelli subalterni si sono infine ritrovati, ma non nel dialogo: si sono uniformati nella direttrice consumistico-capitalistica. Il dialetto, un tempo arma di protesta sociale, rischia di ridursi a rumore di fondo in un mondo che ha preferito la comodità dell’omologazione alla scomodità della verità.
Il dialetto possedeva intrinsecamente una carica eversiva perché tracciava un limen: tra chi sapeva e chi non sapeva, tra città e campagna, tra il palazzo e la terra. Era una barriera di classe che, paradossalmente, proteggeva l’identità del subalterno.
Oggi, quel confine è evaporato nella direttrice consumistico-capitalistica. La critica di Fo, attraverso il recupero della matrice giullaresca, evidenzia come l’omologazione linguistica sia il sintomo di una sottomissione più profonda. Se oggi non avvertiamo più la tensione tra dialetto e lingua ufficiale, non è per aver risolto le disuguaglianze sociali, ma per essere riusciti a renderle invisibili attraverso un linguaggio standardizzato in grado di annullare il conflitto. E oggi chiudo con un po’ di sano pessimismo: forse non abbiamo più bisogno del grammelot perché non abbiamo più niente di così scomodo da dire che la lingua ufficiale non possa già edulcorare.